
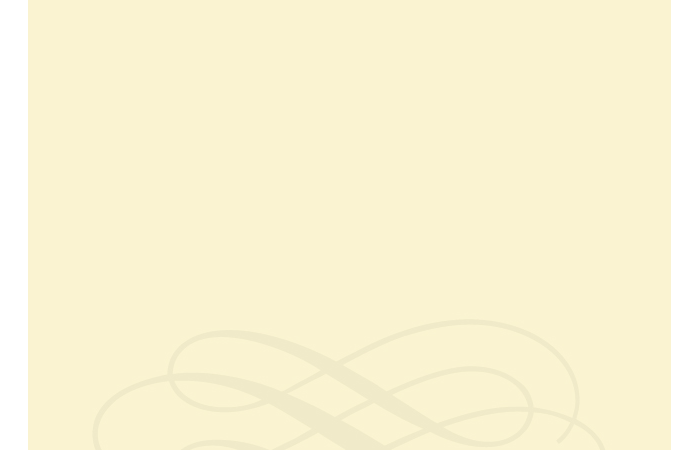
L’opera di William Xerra ha conosciuto diversi stadi di svolgimento, divenendo un modo di stratificare esperienze pittoriche e di dar luogo a una riflessione analitica e poetica sui procedimenti della pittura e della creazione di immagini e significati.
Dalle esplorazioni affini a certa arte performativa o concettuale, vissuta con una certa ironia, compiute fra gli anni Sessanta e Settanta, Xerra ha mutuato, negli anni immediatamente successivi, la possibilità di un dialogo fra l’origine dei materiali del suo lavoro, l’uso della pittura come rivestimento o rivelazione della forma e la presenza della parola come commento e completamento del processo mentale nel quale la sua azione creativa si configura. Da qui l’attenzione per il frammento, per il ricupero di parte di dipinti antichi, di manoscritti, di fogli e carte di varia natura, ritrovati sui banchi di qualche rigattiere o in archivi improvvisati, e la loro traduzione in punti di partenza per l’aggregazione di segni che rivitalizzano quei materiali, trasformandoli in altre proposte di senso.
Xerra agisce così come archeologo e come restauratore, non solo perché mima i processi messi in atto da chi fisicamente pone mano a dipinti antichi, disponendone i lacerti su telai “interinali” per lavorare sulla loro residualità a una nuova costruzione di permanenza, ma in quanto cerca di rivelare ciò che resta di una traccia e fissarla in una dimensione temporale e mentale compiuta. L’uso della pittura è allora integrazione, commento e ritorno a una nuova possibilità di vita di quel lacerto. La sua poetica del frammento si distingue pertanto dal semplice uso formale dei frammenti di immagini, parole e materiali, che è stato all’origine dei collage e degli assemblage cubo-dadaisti o neo-dadaisti, per acquisire una maggior coscienza del legame che ogni atto di scelta e conservazione pone nei confronti di quella traccia anche anonima di un’azione espressiva o comunicativa. L’intervento pittorico o la registrazione di un contratto agrario possono avere così un valore, se non identico, almeno simile, come spunto per dichiarare un incontro tra un passato dimenticato e un presente che cerca di arrestare il deperimento, la dimenticanza. Il processo messo in atto da Xerra si fonda dunque soprattutto su una dialettica di memoria e oblio, dove uno si completa nell’altro, non potendovi essere memoria senza oblio e viceversa. In questo senso possiamo anche intendere l’introduzione della parola-chiave della sua concezione estetica, quel “Vive” derivato dall’intervento del correttore di bozze che in fase redazionale così segnala la necessità di salvare l’integrità di qualcosa che è stato, forse erroneamente, indicato come elemento da cancellare o annullare. Dal significato originale, di un messaggio in codice di carattere tecnico, la parola recupera il suo imprendibile valore metaforico e metafisico, potendosi leggere come asserzione riguardante la persistenza della realtà di un’immagine magari illeggibile o il rimando alla verità di un segno ingannevole. Il suo “Vive” diventa così affermazione di un presente che va oltre la naturale dissoluzione delle cose, segno di fede o fiducia in una permanenza che vince la transitorietà.
In tempi più recenti, poi, all’insieme delle sollecitazioni provocate dalle immagini desunte dal passato o autonomamente create, sulla base sempre di ricuperi di tracce pittoriche anonime o di altri spunti archeologici, si è andato sovrapponendo un altro signum individuato da Xerra come motivo discriminante di un atteggiamento che riguarda tanto il processo dell’artista quanto la posizione di chi sosta nelle trame del pensiero. Questo signum indica un’altra consapevolezza, quella di chi sa che ogni realtà visibile è e può essere un inganno, nel senso che la creazione di immagini non è che un simulacro e che ogni affermazione è sempre relativa. Da qui l’adozione dell’“Io mento” come posizione paradigmatica, filosofica, oltre che indice visivo di una insorgenza dubitativa nei confronti dell’apparenza delle cose. L’“Io mento” attorno al quale Xerra ha elaborato anche un intelligente testo, che riassume il gioco dell’aleatorietà della creazione, non è da intendersi come negazione della verità, ma come coscienza critica, un altro dei segnali di dubbio con cui si qualifica la posizione della modernità, quale autocritica nei confronti del dato concreto, fino a ritornare all’enigma della Sfinge, all’impossibilità di dare una risposta compiuta e definitiva alle illusorietà con cui la realtà stessa si pone.
La combinazione o sovrapposizione dei due, poi – il “Vive” e l’“Io mento” – non si risolve in contraddizione, ma diventa un completamento di senso e allude all’apertura che entrambe le affermazioni contengono, proiettandole come parole-immagine programmatiche sullo sfondo dei procedimenti di cui appaiono commento o forma di dirottamento, rimanendo in bilico fra due condizioni di definizione dell’esistenza.
Francesco Tedeschi
Professore associato di Storia dell’arte contemporanea presso
l’Università Cattolica di Milano.
William Xerra: una dialettica del frammento, tra verità e menzogna

